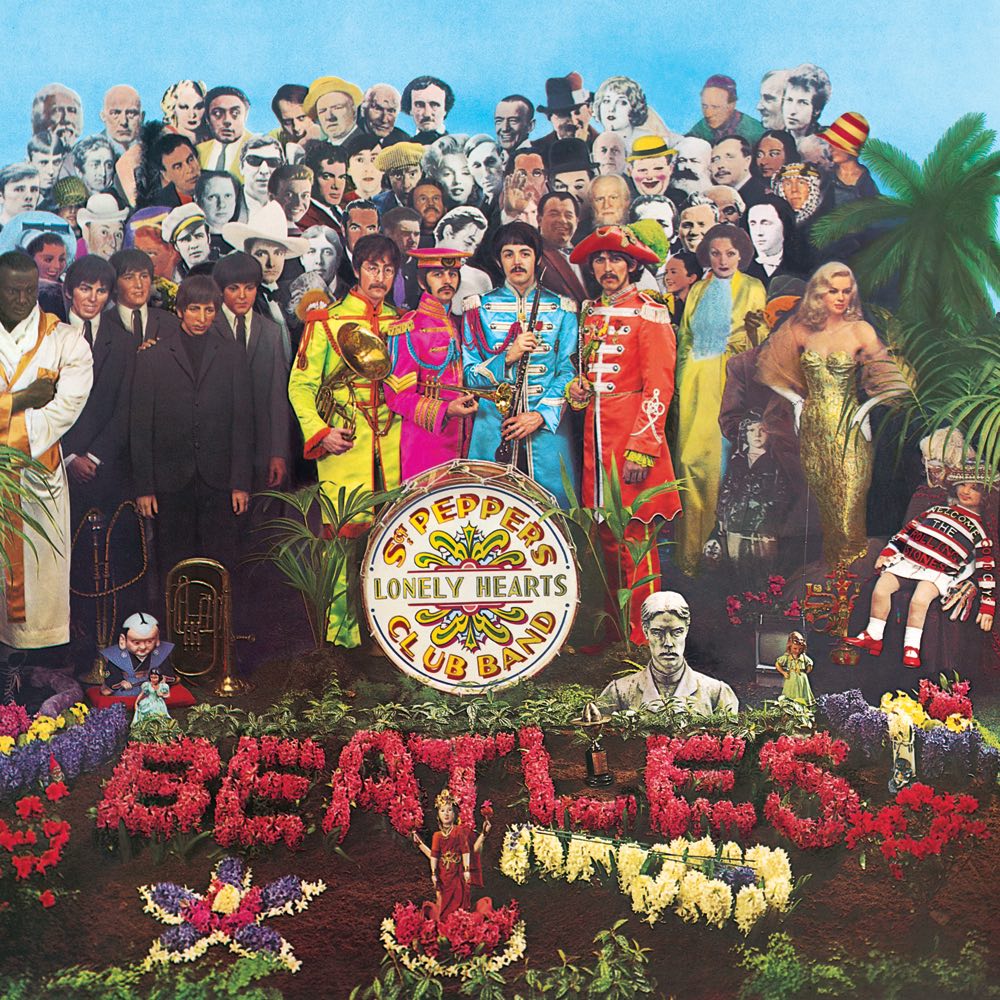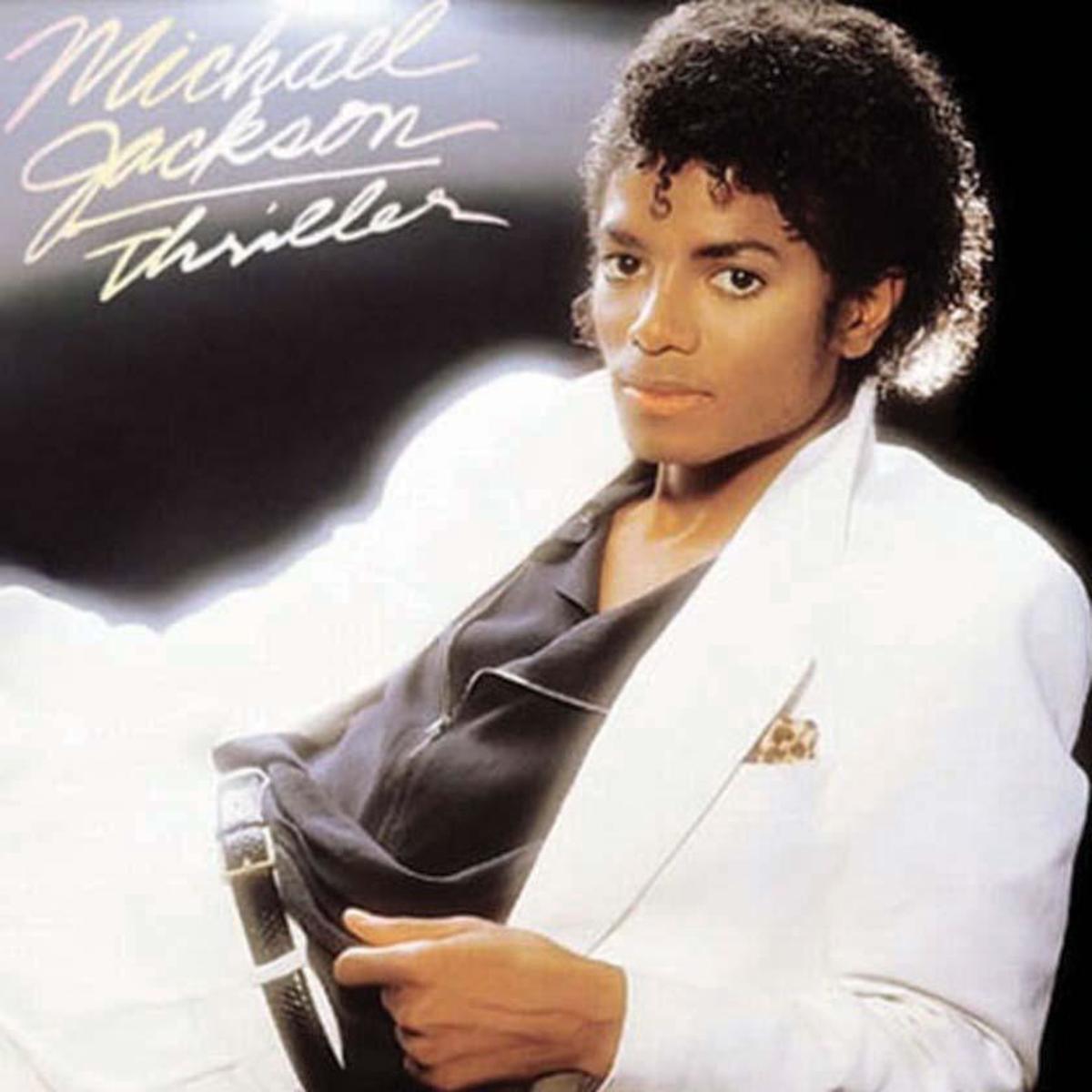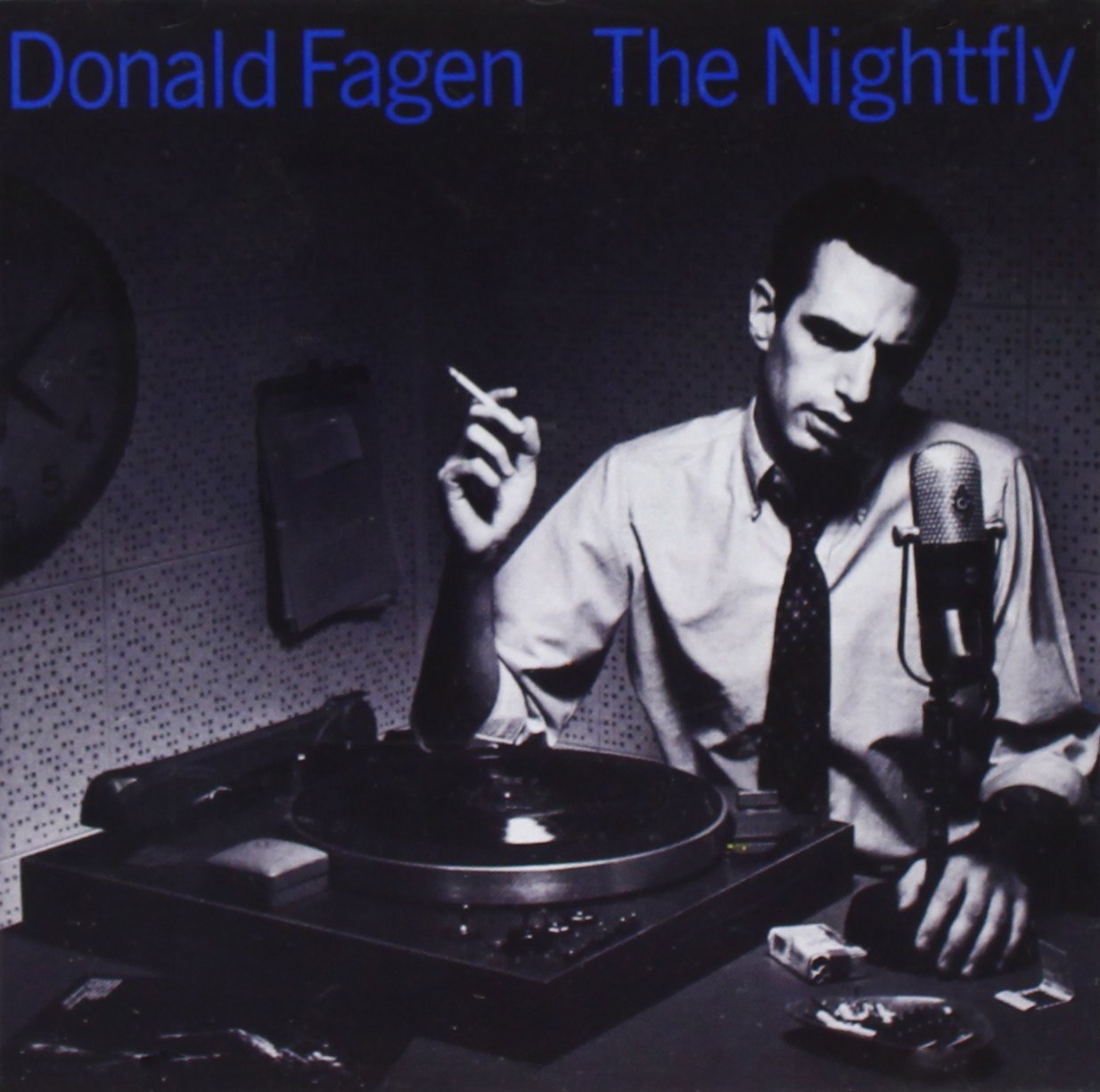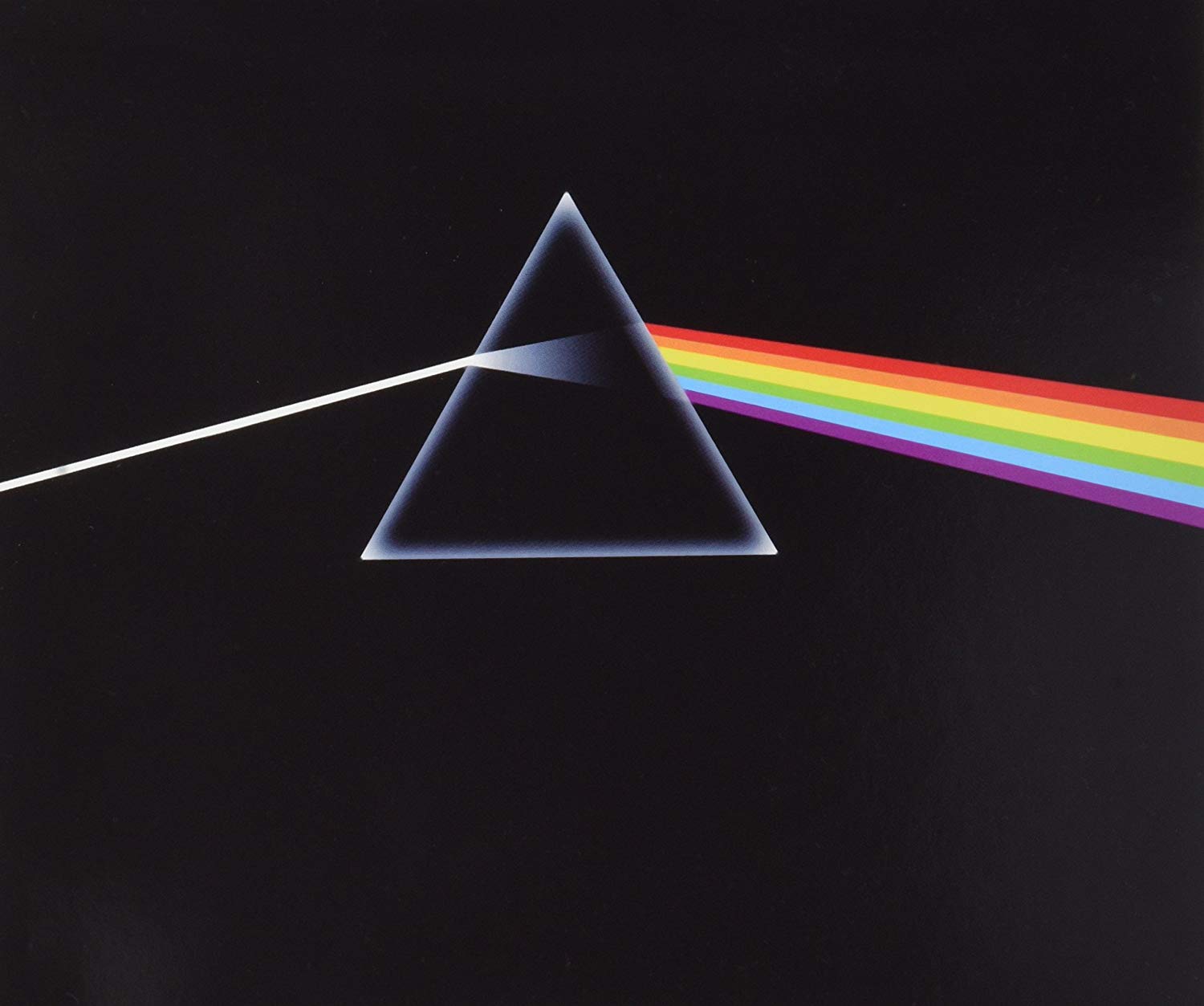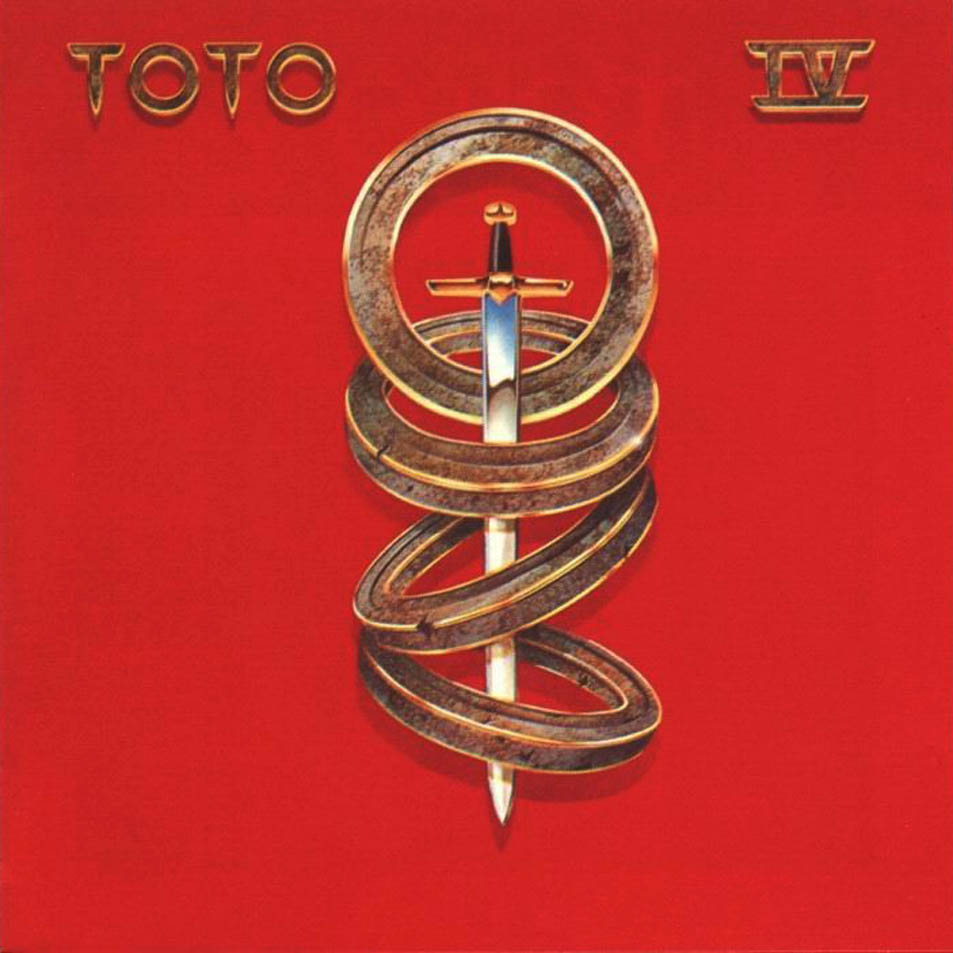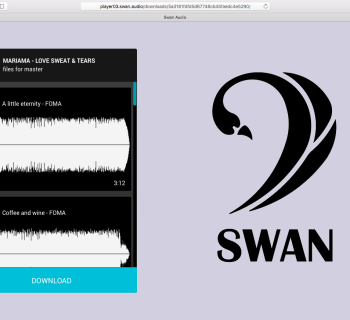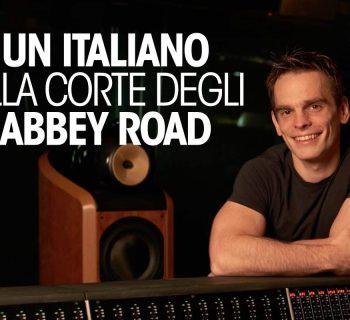Rodolfo Foffo Bianchi non ha bisogno di presentazioni nel mondo del recording e live italiano. La sua pluridecennale esperienza lo hanno reso ormai una leggenda in Italia. Pochi altri fonici hanno avuto il privilegio di lavorare con così tanti artisti, e ancora meno sono ancora in attività. Foffo conosce tutto del suono.
Dall’alto della sua monumentale esperienza, è arrivata l’opportunità di realizzare un’intervista per esplorare quella che lui chiama la filosofia del suono, un’idea tanto facile da pensare quanto difficile da raggiungere. Foffo ha le idee chiare e noi le abbiamo scritte su carta!
LP Dopo tutti questi anni di esperienza, sei passato dall’analogico puro al digitale più spinto. Ogni epoca ha avuto un suono, quanto di questo suono dipendeva dalle macchine e dai loro limiti e quanto, secondo te, dal fonico?
FB Non c'è dubbio che il suono, una volta finalizzato all'uso e consumo dell'ascoltatore, sia sempre stato condizionato e caratterizzato in larga parte dalla gestione umana più che dall'utilizzo della tecnologia, comunque indispensabile compagna per assecondare in varie epoche determinate scelte. Basta pensare storicamente al passaggio dallo standard monofonico a quello stereofonico attraverso le variegate tecniche di ripresa; dalla costruzione invasiva delle echo room alla più snella dotazione delle EMT plate fino all'avvento dei riverberatori digitali; dalla progettazione sempre più evoluta di mixer in grado di processare in analogico (prima) o in digitale (poi) un numero crescente di segnali audio in arrivo da destinare alla fase di missaggio; dalla costruzione di un registratore monotraccia a nastro all'evoluzione di macchine analogiche 2-4-8-16-24 piste sostituite nell'era digitale da superfici multi traccia computerizzate; da ingombranti e costosi outboard dedicati all'equalizzazione e/o alla processione dinamica dei segnali all'avvento del plug-in…
Tutto ciò per capire la portata del servizio che nel tempo la tecnologia, intesa come risultato della ricerca scientifica, ha reso alla elaborazione del suono. Ciononostante ritengo fermamente che la caratterizzazione del suono che in ogni epoca ha contraddistinto la storia dalla discografia, sia attribuibile a vantaggio dell'uomo, inteso come operatore di scelte creative che hanno conferito al suono una personale riconoscibilità. Un esempio: il sound dei Beatles condensato in Sgt Pepper, mirabile fusione di scelte musicali (Beatles/George Martin) con il talento ingegneristico di Geoff Emmerich espresso nella ricerca timbrica, nel panorama stereo dei segnali, nella creazione dei piani sonori. Tutto questo è opera dell'intelletto dell'uomo prima del necessario concorso delle macchine. Per non tacere delle meraviglie sonore che un tal Bruce Swedien ci ha consegnato costruendo ed elaborando il "Q Sound", marchio di fabbrica da oltre un cinquantennio della discografia di Quincy Jones.
E poi ancora un tal Roger Nichols, compianto sound engineer dell'incomparabile Nightfly di Donald Fagen e di tutti i capolavori degli Steely Dan. Mi potrei dilungare con molti altri non meno meritori esempi: tutti porterebbero alla mia conclusione che il suono, inteso in qualsiasi supporto codificato come sintesi di ripresa, giustapposizione dei livelli, posizione nel panorama stereo, definizione timbrica e spazialità di molteplici segnali, debba ritenersi innanzitutto risultato della creatività umana.
LP Parlando di suono, un album jazz ha delle sue peculiarità come quello rock o di differente genere. Ti sei fatto certamente un’idea circa i rapporti tra gli strumenti, le equalizzazioni, le dinamiche e il mix finale.
FB Ogni genere musicale implica dal punto di vista della realizzazione sonora, dal vivo e in studio, scelte appropriate a seconda di ben distinte peculiarità che ne determinano la riconoscibilità. Per i progetti musicali di estrazione jazzistica, limitatamente ai piccoli organici (trio, quartetto, quintetto, sestetto) ho sempre cercato di assecondare il sound rispettando l'andamento tipico di una esecuzione musicale che per natura è più strumentale che cantata e lasciata in larga parte all'improvvisazione di uno o più solisti; donde la necessità di conservare una dimensione acustica per suoni generati da strumenti acustici quali la batteria, le percussioni, il pianoforte, il contrabbasso, il sax o la tromba ecc.
Questo scenario ha sempre richiamato la mia attenzione a una visione globale del progetto, concependo la ripresa sonora degli strumenti in funzione della registrazione o riproduzione musicale di un insieme, partendo dal principio che l'esecuzione di un ensemble costituito da strumenti acustici che suona normalmente musica soft debba essere ripresa (registrata) e riprodotta il più fedelmente possibile, definendone il carattere timbrico e l'andamento dinamico. Per ottenere questo risulta determinante la scelta dei microfoni da destinare ad ogni strumento e il suo adeguato posizionamento; pertanto in studio utilizzo di solito microfoni a condensatore che sono più idonei per definizione ad ottimizzare la captazione timbrica e dinamica di ogni strumento. Se anche l'ambiente ove viene fatta la ripresa risponde in maniera congrua alle sollecitazioni sonore, ecco che il gioco è fatto!
Una corretta registrazione dell'evento, a questo punto, determina un buon 80% del missaggio, dal momento che i microfoni, destinati per immagine e posizione alla ripresa, hanno già prodotto la definizione timbrica delle sorgenti, rendendo quasi vano l'utilizzo degli equalizzatori, e dal momento che l'andamento dinamico di una esecuzione strumentale di genere jazzistico va assolutamente salvaguardata dall'improvvido uso dei compressori. Infine, dando per scontato che la qualità del suono sia sempre una diretta conseguenza della bravura dello strumentista che lo genera, non ci sarà da operare gran che per ottenere in mixing un buon bilanciamento delle tracce registrate.
Ben diverso il discorso di quando vengo chiamato in causa per la gestione di un evento rock. Mi trovo qui di fronte a uno stile musicale caratterizzato da sonorità aggressive e roboanti scandite, con dinamica costante, da batteria, basso e chitarra elettrica, contraddistinte da rilevanti transienti veloci (picchi), generati in gran parte dalle pulsazioni ritmiche di cassa e rullante per il cui trattamento si dovrà necessariamente fare uso dei processori dinamici. Qui si impone una distinzione, laddove la scena non sia la location di un evento live bensì uno studio recording, la qual cosa comporta l'applicazione di criteri diversi alla gestione del suono: negli eventi dal vivo bisogna riuscire a convivere con la sonorità che si genera sul palco fino al punto che il contenimento dei rientri sui numerosi microfoni presenti, in maggioranza dinamici, non vada a inficiare la qualità del balance finale che io rimando sull'impianto di sala; in studio invece le tecniche di ripresa sono assoggettate alla imprescindibile necessità di garantire la miglior definizione e pulizia del suono durante il transito dei vari segnali da registrare.
Qui, rispetto al live, non posso prescindere dall'impiego di microfoni nobili (Neumann, AKG, Bruel&Kjaer, Royer, Shoeps ecc...) storicamente dedicati alla ripresa d'ambiente, che in studio assumono un ruolo fondamentale per determinare il suono globale (ad es. della batteria): due mic condenser per l'ambiente rear, e due posizionati nella parte più profonda dello studio per l'ambiente large, oltre a tutti i numerosi microfoni posizionati per la ripresa ravvicinata di ogni componente della stessa. In studio, la sala di ripresa sostituisce il palco ed ogni musicista affida in maniera autonoma alle cuffie il monitoraggio di quanto viene eseguito, il che agevola insieme all'utilizzo di pannelli divisori fono-assorbenti un consistente abbattimento di qualsiasi rientro indesiderato.
Riguardo ancora alle differenze che sorgono nella gestione del suono per i due suddetti scenari una mia attenzione particolare va rivolta all'impiego dei processori dinamici: detto che la mia filosofia è quella di assegnare alla compressione dei segnali una funzione "taumaturgica", che rispetti sempre l'andamento dinamico della composizione e dell'arrangiamento, ne consegue che dal vivo l'utilizzo della compressione è solo dedicata - quando e soltanto ve ne sia la necessità - alla riduzione dei transienti veloci (picchi) generati quasi sempre dalla cassa, dal rullante, dal basso dalle voci. In studio talora, soprattutto nella fase del mixaggio, mi piace utilizzare il compressore in maniera "artistica", ove io decida che il processore debba finalizzare la natura di un suono: ovviamente tutto questo richiede larghi tempi operativi e sofisticati mezzi di impiego che non sono concessi per la ripresa sonora di una esibizione dal vivo.
Un altro elemento di rilevante importanza da considerare per i due scenari e per tutti i generi è la funzione del riverbero, parametro fondamentale per la determinazione dei piani sonori nel mixaggio, data la necessità di collocare ogni strumento (voce inclusa) in un proprio ambiente. Partendo dal presupposto che ogni sorgente sonora risenta della qualità dell'ambiente fisico in cui si propaga, è facile capire che in uno studio recording la sala di ripresa, acusticamente corretta per definizione, costituisca già un buon punto di partenza per una naturale riverberazione di strumenti come la batteria in particolare: qui la dimensione dell'ambiente fisico, mediante il posizionamento di microfoni dedicati, determinerà l'ampiezza, il decadimento e il colore del riverbero.
Dal vivo, quasi sempre in assenza di un ambiente fisico acusticamente corretto, sarà giocoforza ricorrere all'impiego dei riverberatori digitali che generano ogni tipologia di riverbero desiderato mediante algoritmi dedicati. Fatte queste dovute osservazioni, sarà più facile comprendere le differenze operative tra un missaggio fatto in studio, rivedibile e perfettibile in momenti successivi, e un missaggio operato in tempo reale durante l'andamento di un concerto live, dove si impone di restituire a un impianto audio installato il bilanciamento definitivo per livello, dinamica e timbro di tutte le sorgenti sonore. A ogni modo per me vale la regola che in studio un buon mix sia figlio di una buona registrazione, come un buon mix live eseguito per la diretta di un qualsiasi evento live (rock, pop, jazz che sia) è sempre figlio di una corretta ripresa dei segnali che provengono dal palco.
Conseguenza di quanto ora detto è che una errata ripresa dei suoni, in entrambi gli scenari e per qualsiasi genere, produce inevitabilmente un risultato negativo circa la qualità audio del missaggio finale. Da questo assioma partono i miei personali principi o linee guida che determinano il mio modus operandi in questa importante fase operativa della realizzazione di una qualsiasi produzione musicale. Va detto subito che il missaggio implica un congruo bilanciamento di più segnali (tracce), registrati in un supporto analogico o digitale (registratore multitraccia) e assegnati tramite il mixer (consolle) a un uscita L+R, onde ottenere un risultato gradevole o comunque utile alla necessità del prodotto finale. Ogni mixer professionale ha un approccio tridimensionale al processo di missaggio, in quanto in modo funzionale ragiona in termini di "altezza" (gamma delle frequenze utili), "profondità" (giusto ambiente per ogni strumento) e "spazialità" (ogni strumento posizionato correttamente nel panorama auditivo dell'ascoltatore).
Evidentemente nel primo caso si farà ricorso all'equalizzazione, nel secondo a effetti tipo reverberi o delay, nel terzo al panning. Il bilanciamento è riferibile alla giustapposizione di livelli (scala di valori misurata in dB) fra le varie tracce che compongono l'assunto sonoro: si dovrà pertanto far convivere le sezioni ritmiche (batteria, percussioni, basso) con le sezioni armoniche (tastiere, chitarre, archi, fiati, cori) a beneficio della voce che, in ogni progetto musicale, risulta l'elemento fondamentale in quanto destinataria della parte melodica e letterale. Bisogna quindi aver cura in primis di ben visualizzare all'interno di ogni arrangiamento il balance interno delle sezioni ora dette, per far "suonare" bene ritmicamente il brano musicale nel contesto degli strumenti che ne eseguono la tessitura armonica, per far rilucere infine nel contesto sonoro la performance vocale: facile a dirsi ma arduo da ottenere!
C'è da dire in proposito che la tecnologia applicata al suono ha, nel corso degli anni, notevolmente aiutato l'operato del mixing engineer dotando gli studi professionali di sofisticati outboard progettati e creati per agevolare scelte sempre più risolutive per la precisione e definizione del "balance": mi riferisco soprattutto all'utilizzo degli equalizzatori parametrici che conferiscono ad suono trattato quel particolare "colore", una volta pulito da frequenze indesiderate e/o reso più dettagliato e definito nel contesto di una sonorità globale. Mi piace pur tuttavia ricordare che l'approccio al missaggio deve essere assolutamente consapevole; chi si appresta a mettere mano a livelli, equalizzatori, compressori, limitatori, noise gate, riverberatori, deve avere le idee chiare tenendo ben presente il tipo di prodotto da confezionare e il tipo di sonorità che si intenda ottenere. Per mia deontologia non sono ammessi fuorvianti tentativi fatti alla cieca.
LP Seguendo queste filosofie sul suono, hai dovuto adattarle nel tempo secondo le tecnologie che arrivavano, e, nel caso affermativo, hai trovato differenze importanti tra le tecnologie usate?
FB Chi ha fatto del suono la sua professione non può non aver subito le inevitabili influenze indotte da trend che hanno caratterizzato in varie epoche l'andamento della musica riprodotta, tanto quella inglobata nel patrimonio discografico quanto quella fruita dal broadcasting e dal mondo dello spettacolo. Un esempio per tutti è l'importanza concessa dal sound engineering all'elemento ritmico con l'avvento della disco music degli anni '70: qui la disponibilità della registrazione multitraccia su apparati analogici costantemente allargati (da 2 a 3/4/8/16/24 tracce) ha decretato l'esigenza, divenuta poi metodologia, di registrare ogni elemento (pelli e piatti) della batteria mediante la tecnica della ripresa ravvicinata che permettesse in missaggio la possibilità di assegnare separatamente a cassa, rullante, tom, timpano e basso un dosaggio di livello sonoro ben più accentuato in altezza e dinamica in confronto alle produzioni discografiche di epoche precedenti.
Già questo avrebbe conseguentemente comportato in un operatore del suono lo spostamento da un'attenzione globale ad una disamina particolare dell'apparato sonoro, imponendo ai professionisti dello studio recording la conoscenza nonché l'esercizio pratico di tecnologie atte a soddisfare le esigenze sonore di un genere musicale destinato al ballo in discoteca, oltre che alla commercializzazione discografica. Tecnologie che storicamente vanno sempre a braccetto con le metodologie: basti pensare alla progettazione di superfici di controllo (mixer) sempre più elettronicamente evolute le cui molteplici e sofisticate funzioni avrebbero aggiunto al metodo tradizionale (manuale) una marcia in più nella fase di missaggio mediante l'automazione dei canali.
Dal trattamento del suono "nature" attraverso una captazione microfonica che lasciasse inalterato nel suo transito la sorgente sonora, alla tecnica di trattamento dei segnali audio per variarne il contenuto timbrico mediante equalizzatore, impiegato tanto nella fase di ripresa quanto soprattutto nella fase di post produzione dei segnali registrati; dalla commercializzazione e sviluppo dei processori dinamici (compressore) in studio e/o in applicazione live, al fine di ottimizzare il livello del segnale sonoro riducendo di contro l'escursione dinamica del segnale: nati in origine per modificare i segnali in uscita da microfoni e trasmettitori audio al fine di evitare eventuali distorsioni di ampiezza che ne avrebbero durante la ripresa impoverito significativamente la qualità, i compressori, per il loro crescente sviluppo e utilizzo, sono nel tempo divenuti un "vademecum" dei professionisti del suono che abbinano al loro uso tecniche particolari (soft/hard compression, compressione parallela, variable-mu, etc. ) secondo la tipologia dei compressori (VCA, J-FET, optometrici), fino a modificare deliberatamente il carattere sonoro dell'assunto musicale processato.
Così pure il riverbero, per il trattamento dell'ambiente da assegnare in mix ad ogni strumento, ha offerto in tempi diversi l'esercizio di tecniche dedicate, tanto da influenzare notevolmente l'elaborato sonoro definitivo caratterizzandone il timbro, il colore e la spazialità. Attualmente il mondo della musica prodotta si avvale dell'evoluzione dei convertitori digitali che, attraverso l'innalzamento delle frequenze di campionamento, forniscono la codifica audio-video migliore; per arrivare all'uso incondizionato di plug-in che soddisfino attraverso algoritmi dedicati ogni richiesta da parte di chi voglia operare sul suono.
Ho professionalmente vissuto durante la mia carriera il passaggio di tutte queste fasi, cercando di individuare in ognuna di esse quei benefici che incrementassero la mia cultura o filosofia del suono attraverso la cura e la maniera di "ascoltarlo" (corretto balance dell'insieme sonoro, dettaglio e congruità in frequenza di tutta la gamma timbrica, definizione della spazialità ed ambientazione dei piani sonori, gradevolezza di ascolto del suono riprodotto in qualsiasi apparato acustico e in qualsiasi condizione ambientale) e rifiutando di contro le storture generate da improvvide mode, una su tutte il "loudness war".
LP Sei anche un fonico live: è più facile avere una filosofia del suono in studio o in live? E quanto, oggi, conta la richiesta della produzione sul suono del live?
FB Parlare di "filosofia del suono" equivale a rapportare e applicare al medesimo dei comportamenti operativi, derivanti da un tipo di cultura musicale e da molteplici esperienze maturate in studio e/o dal vivo, tali da determinarne l' "imprimatur".
Una volta appurato quello che per me è il concetto di filosofia del suono, ritengo che il metodo (mentalità) di pormi di fronte alla gestione di un evento musicale non sia granché dissimile per entrambi gli scenari, tenendo pur sempre presente che l'attività svolta in studio mi può indurre talora a scelte particolari, per esigenze mirate a confezionare un audio da "laboratorio" piuttosto che da "concerto": per esempio la scelta di gestire in fase di missaggio il gruppo batteria con la compressione parallela enfatizzandone volume e presenza, ma preservando il segnale originario, o processare un composit di voci/cori mediante un equalizzatore parametrico dedicato per ottenere una migliore gradevolezza timbrica, o assegnare al mix un panorama stereo più esteso per una migliore identificazione della spazialità delle sorgenti. Per il resto vale per me la regola che l'andamento di un corretto amalgama sonoro sia l'inevitabile risultato di una adeguata ripresa e di un congruo bilanciamento dei segnali in arrivo.
Nel live di oggi, in virtù di esigenze manageriali e artistiche, la richiesta della produzione del suono sta assumendo - a parer mio - pieghe impensabili rispetto a un recente passato; qui si è insediata la tendenza della spettacolarizzazione ad ogni costo dell'evento, soprattutto nel mondo pop-rock- che ha determinato nell'utenza comportamenti e aspettative: ormai i concerti sempre più si vedono e sempre meno si ascoltano! Di fronte a scenografie hollywoodiane, a un light design che impone vorticosi e invadenti effetti luminosi creati per riempire volumetrie di palchi enormi, a schermi giganteschi che riproducono in video tutto l'andamento del concerto, si accampano decine di migliaia di persone che in questo scenario si sentono co-protagoniste, insieme all'artista pop o alla rock band di moda, vivendo l'evento molto più da spettatori che da ascoltatori.
In questo film quale ruolo riveste la musica e il suono in particolare? L'installazione di impianti audio (line array) di notevole caratura per qualità e quantità di diffusori atti alla copertura sonora di grandi o medi spazi, si è accompagnata di pari passo alla magnificenza delle progettazioni sceniche ora dette per assecondare oltretutto una recente tendenza da parte degli artisti a replicare dal vivo lo stesso contenuto sonoro del brano registrato su CD, nell'intento di ri-suonare fedelmente dal vivo lo stesso arrangiamento, compresa la riproduzione campionata di parti strumentali ed effetti altrimenti non ripetibili dalla band che accompagna l'artista. Tutto ciò comporta per il sound engineer e operatori annessi:
- a) la gestione in tempo reale di un numero sempre più crescente di canali adeguatamente supportati da mixer digitali oltremodo performanti, dove l'hardware è stato quasi del tutto sostituito da software e da banchi di plug-in atti a clonare, se pur approssimativamente, tutti quegli ingombranti outboard con i quali ho felicemente convissuto per anni
- b) la necessità di sottostare pure nei concerti dal vivo all'attuale trend dell'industria musicale che impone uno sconsiderato "loudness war" - tipico del processo di mastering di ogni formato audio - per registrare, produrre e diffondere musica con livelli di volume progressivamente più alti ponendo i produttori del suono nella condizione di "sfidarsi" in una sconsiderata guerra dei decibel con un orecchio più rivolto alla quantità che alla qualità, pur consapevoli che "pompando" (mediante compressione o limiting del livello audio) il volume complessivo dell'esecuzione musicale si vada a creare una sorta di massificazione sonora della stessa: così ogni brano contenuto nella scaletta uniformemente e complessivamente "suona" forte dall'inizio alla fine, appiattito contro il tetto massimo del volume, tutto questo a discapito ovviamente dell'espressività dinamica e timbrica del brano suonato e riprodotto.
LP Il rapporto tra fonico, artista e produzione: dopo questi anni com’è cambiato e in quale direzione?
FB Premessa: non ci sono regole codificate che determinino il rapporto professionale e comportamentale fra chi è delegato al ruolo di ingegnere del suono e l'artista. Nella mia longeva carriera ho sempre gestito il mio ruolo in maniera molto autonoma e personale cercando di conquistare sul campo quella fiducia da parte dell'entourage artistico che ponesse il mio operato ben oltre la normale funzione di operare un corretto servizio professionale. Sia in studio che dal vivo ho sempre mirato ha proporre idee personali, più che cercare la normalità e per normalità intendo tutta quella serie di conoscenze operative che fanno parte del background professionale di un ingegnere del suono e/o di un produttore artistico.
Quello che per me va oltre la normalità è generato dal requisito, fondamentale, della creatività al servizio di quella che è l'arte più creativa, e cioè la musica. Creatività, per esempio, è riuscire ad assegnare ad un insieme di suoni un balance ed una spazialità che alla fine caratterizzi la riconoscibilità di un progetto musicale. In questo, appunto, mi è sempre piaciuto propormi, cercando di apporre un mio marchio al lavoro affidatomi. Ovviamente devi essere in grado di proporre confidando su un know how acquisito nel tempo, attraverso l'approfondimento dell'ascolto di tanta musica che alla fine ha determinato una mia filosofia del suono.
Tutto ciò premesso, devo purtroppo ammettere di non ravvisare quasi più, ai tempi d'oggi, quella riconoscibilità sonora nei progetti musicali prodotti dalla discografia e dallo show business di casa nostra. Come se il rapporto fra l'operatore del suono e la produzione artistica sia scaduto ad un normale servizio clientelare di routine, scandito da mode spesso inconsulte e non dall'inventiva. Per altro, un ventennio ed oltre di ininterrotta collaborazione la dice lunga sul mio rapporto professionale ed umano con Elio e le storie tese: la longevità del rapporto spiegherebbe già di per sé il rispetto professionale e la stima reciproca che hanno poi generato e cementato un vincolo di amicizia al di là delle relazioni di lavoro.
Da parte mia ho da subito capito che lavorare con un gruppo come EELST avrebbe richiesto un approccio particolare, diverso dalla comune gestione di un gruppo o di un artista rock /pop, data la poliedrica attitudine del gruppo a creare progetti musicali sempre innovativi ed originali; insomma ho avuto presto la sensazione che la loro musica dovesse essere gestita, a livello di espressione sonora, in maniera meno convenzionale e quindi più creativa rispetto allo stile monocorde della musica pop. Questa mia intuizione devo dire è stata da subito assecondata dal gruppo che ha condiviso le mie idee o il mio modo di approcciarmi al loro sound fino a farlo diventare nel tempo un marchio di fabbrica da tutti invidiato.
Tour dopo tour, unitamente a molteplici esperienze a ridosso delle loro produzioni discografiche, si è creato un collante quasi necessario fra il mio operato e la loro attività di musicisti: la loro eccelsa bravura ha sempre punzecchiato la mia fantasia e, siccome mi ritengo un creativo mi sono sempre adoperato, nei confronti del loro talento, ad ottenere il meglio per rendere giustizia alle loro virtuose performance. Per ottenere questo risultato ho riascoltato fino alla nausea le registrazioni di innumerevoli concerti per valutarne pregi e difetti, ho fatto prove su prove alla ricerca del "perfettibile", cercando di apportare sempre qualcosa di diverso alla realizzazione sonora dei loro eventi musicali, certo che il sound di EELST al di là di essere gestito debba essere necessariamente prodotto.
Di riflesso ho sempre ricevuto dagli Eli incondizionati attestati di soddisfazione e stima di cui mi ritengo ripagato oltre misura ben consapevole di averle guadagnate sul campo. Esperienza, dedizione e passione alla mia professione nonchè una certa dose di personalità: questi gli ingredienti che hanno reso attuabile fra me e gli Eli una lunga e felice convivenza.
LP a quali album internazionali partiresti per indicare le direzioni circa la filosofia del suono adottata per un genere musicale?
FB La discografia, nell'arco della sua storia, ci ha lasciato dei capolavori assoluti da annoverare a pietre miliari, oltre per l'intrinseco valore artistico, per il tracciamento di tendenze e metodologie nel campo della elaborazione del suono. Pertanto parlerò di seguito di quei dischi storici e dei suoi mentori che hanno notevolmente arricchito la mia cultura musicale nonché il mio background professionale.
SGT. PEPPER'S Lonely Hearts Club Band (Beatles/1967)
Tralasciando in questa sede di parlare dell'enorme influenza artistica e culturale che questo disco, fautore dei concept album, avrebbe trasmesso alla produzione discografia degli anni avvenire, mi piace qui celebrarne le innovazioni tecniche che Geoff Emerick (sound engineer) e G.Martin (producer) apportarono nel mondo dello studio recording, tanto da costituire la colonna sonora di un'epoca inventando e sconvolgendo i confini della musica pop: dal "varyspeed" o "variatore di frequenza", un ingombrante macchinario a valvole che alimentato elettricamente poteva forzare su o giù la corrente alternata ai due estremi dei regolari cinquanta cicli al secondo, inducendo in fase di registrazione un cambio di velocità atto ad alterare in più o in meno lo spessore timbrico del suono - ad esempio della voce - una volta riprodotto a velocità normale; alla necessità di estendere l'overdubbing (sovraincisione) oltre le possibilità fisiche delle macchine di registrazione dell'epoca (Ampex, EMI j37, Studer, Scully) dotate di quatro tracce, utilizzando di volta in volta la pratica del premix su ogni take scelta come migliore, al fine di acquisire un nuovo spazio utile per un'ulteriore sovrapposizione vocale o strumentale da registrare sul primitivo nastro a quattro piste; dalla caratterizzazione stereofonica del disco rispetto alla tradizionale modalità mono delle precedenti produzioni musicali.
A seguire altre innovazioni, ritenute tutt'ora uno standard, apportate da G.E. durante l'iter realizzativo di Sgt. Pepper sono il close miking metodo della microfonatura ravvicinata, che consisteva nell'approssimare uno o più microfoni nelle vicinanze di strumenti acustici (batteria, chitarra acustica, archi, brass, legni ecc.) al fine di ottenere un suono più pieno e preminente nel mix finale, pratica questa in netto contrasto con i ferrei standard della EMI (che prevedevano altresì il posizionamento dei microfoni lontano da ogni sorgente sonora) la cui violazione avrebbe provocato il licenziamento di Geoff se questi non fosse stato protetto dal potere dei "Fab Four"; l'utilizzo del Direct Imput (D.I.) per registrare il basso elettrico di Paul Mc Cartney, collegando il pick-up dello strumento alla consolle tramite una scatola DI di adattamento dell'impedenza; il vocal double tracking o procedura di raddoppiare su una traccia assegnata una voce precedentemente registrata replicando la stessa stesura melodica e letterale con la stessa intenzione ed intensità al fine di rendere più pieno e marcato il suono della voce. A onore del vero i Beatles potrebbero non essere stati i primi ad adottare questa pratica, ma l'influenza che il loro Sgt. Pepper apportò al mondo del suono registrato fu tale che il V.D.T. sia considerato un loro marchio di fabbrica tutt'oggi largamente impiegato.
THRILLER (Michael Jackson/1982).
È l'album più venduto di tutti i tempi, considerato l'album pop per antonomasia, influenzato da sonorità funk, r&b, soul, rock e disco, ha generato sette singoli ed ha vinto otto Grammy Awards. Uno dei protagonisti chiave, insieme a Quincy Jones, nella creazione dell'album è stato l'ingegnere del suono Bruce Swedien, vera leggenda dello studio recording per aver apposto la sua inconfondibile firma su dischi storici, da Country Basie e Duke Ellington prima di approdare alla corte di Quincy Jones. Con Quincy, vero traghettatore della black music in una dimensione da pop internazionale, Swedien mise in campo tutta la sua meritata fama: esteta della registrazione stereofonica, a partire da Out the Wall (primo disco celebre di Michael solista) sviluppò un metodo per sincronizzare più registratori analogici 24 track, battezzato the acusonic recording process al fine di disporre di più spazio possibile in registrazione, fondamentale quando ogni strumento occupa due tracce.
Così la magnificenza sonora riscontrabile in Thriller, è anche conseguenza del processo della registrazione acusonica. Tralasciando in questa sede di descrivere i passaggi richiesti per attuare tecnicamente questo processo, dirò che il tutto era finalizzato nelle intenzioni di Bruce ad ottenere in fase di missaggio una restituzione accurata dell'immagine stereofonica e della pulizia sonora, migliorandone il senso di larghezza, profondità e chiarezza.
"NIGHTFLY" (Donald FAGEN/1982)
Secondo me disco perfetto in ogni dettaglio, dal suono levigato ed elaborato al limite della maniacalità: normale quando ci sia di mezzo D.Fagen, uno che del perfezionismo aveva fatto una sua religione a fianco di Walter Becker nella gloriosa ditta Steely Dan sotto la sapiente regia sonora di Roger Nichols. Retaggio di Eja e Gaucho per l'inconfondibile cocktail di jazz, pop, blues, funky e soul e per il tocco sofisticato degli arrangiamenti, Fagen adotta in Nightfly una forma compositiva più asciutta, più canzone restringendo gli interventi strumentali; si conferma qui maestro nel manipolare la musica colta producendo una facilità di ascolto inconsueta per il suo stile notoriamente raffinato. Uno dei primissimi album registrati in digitale, se non il primo, lo considero la massima espressione di un suono di assoluta precisione, delicatezza ed eleganza, un disco il cui suono non può essere raffrontato con le opere coeve o successive perché non invecchia mai e mai ha perso alcunché della sua peculiare bellezza.
THE DARK SIDE OF THE MOON (PINK FLOYD /1973)
Capolavoro assoluto, universalmente riconosciuto dalla critica discografica, costituisce tutt'oggi un punto di riferimento obbligato per chi abbia interesse per passione o per professione alla musica. Di questo concept album consacrato a summa è stato detto tutto e di più; qui voglio solo ricordare che l'engineering fu affidato ad Alan Parsons, che aveva già lavorato come assistente in Atom Heart Mother, il quale contribuì attivamente ad apportare all'album alcuni degli aspetti sonori più innovativi per l'epoca contaminando le parti vocali e strumentali con una effettistica volta a conferire ai contenuti musicali e letterali di ogni brano una tensione emotiva, quindi pensata ed applicata in modalità artistica e mai fine a se stessa; mi riferisco ad out board analogici quali tap-delay, flanger e phaser che Parson usava spesso "in cascata" con una camera di riverberazione.
Va detto anche che Parsons riservò alla sonorità finale del disco un sapiente e creativo impiego del reverbero al fine di conferire profondità e spazialità agli elaborati strumentali e vocali di Gilmour e soci. Altre caratteristiche sonore dell'album sono l'uso ricorrente della rumoristica ottenuta dal campionamento di oggetti registrati su frammenti di nastro e riprodotti a loop, come le registrazioni casalinghe di monete tintinnanti, i rumori di fogli strappati, quelli di un registratore di cassa e di una macchina calcolatrice ed altri suoni inconsueti come l'assistente tecnico che corre nella camera di riverberazione o una grancassa elaborata per simulare il battito cardiaco: il tutto per l'esigenza dei P.F. di accompagnare le superbe melodie ed i contenuti letterali con nuove sonorità che nel tempo renderanno il sound psichedelico della band universale ed istantaneamente riconoscibile.
"TOTO IV" / TOTO 1982
Questo è un altro album a cui sono rimasto affezionato da sempre. Il più gratificato per vendite e riconoscimenti (ben sei Grammy Award) nell'arco di tutta l'attività artistica dei Toto; si tratta di un disco dal suono ricco e variegato dove ruvide venature rock si alternano o convivono con il suono più pop di accattivanti power ballad. Già il fatto di aver affidato alcune track all'engineering di un guru del recording quale Al Schmitt, famoso per aver accreditato dischi storici di Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles ecc. la dice lunga da parte di Lukater, Paich, Porcaro & co. circa la volontà di produrre un album che concedesse più all'immediatezza d'ascolto che non agli stilemi del solito rock: da qui la ricerca in studio di un suono più pulito e più morbido, ma non meno esplosivo, che ben si coniugasse con la natura compositiva di brani più votati alla classifica che al culto rockettaro. Così Toto IV diventa un disco campione per i dischi avvenire, modello di un suono efficace ed avvolgente che ti catturi empaticamente al primo ascolto.
LP Cosa ne pensi del futuro della produzione musicale, del ruolo del fonico e del modo di ascoltare musica di oggi?
FB Penso sia arduo ipotizzare il futuro della produzione musicale, in quanto non riconosco nelle produzioni attuali quei parametri e quei requisiti che hanno contraddistinto nei decenni passati la figura del produttore artistico: mi riferisco soprattutto al ruolo che questi rivestiva all'interno del processo di realizzazione del supporto disco/CD accentrando su di sè molti dei compiti, come la selezione e l'arrangiamento dei brani, la supervisione delle sessioni e spesso l'ingegneria del suono. Insomma l'era discografica in cui mi sono trovato professionalmente coinvolto affidava al mio ruolo responsabilità e mansioni che per natura e orientamento accomunavano il termine producer a quello di musicista.
Una volta ogni etichetta - delle tante esistenti - avocava a sé il lavoro per tutte le fasi dell'iter di produzione, da quella contrattuale con l'artista a quella realizzativa, promozionale e commerciale del supporto; adesso le label - le poche rimaste - si devono occupare solo di stampa, promozione e distribuzione. Così nel tempo i producer artistici che realizzavano in nome e per conto di produttori esecutivi sono diventati producer a tutto tondo, diventando i principali intermediari tra gli artisti e le label. Sono cambiati gli scenari soprattutto nella fase realizzativa: non più dischi suonati da organici numerosi in studi di registrazione importanti e arrangiati da musicisti di grido, il tutto avallato da considerevoli budget che esponevano l'imprenditoria discografica alla quasi certezza dell'investimento.
Adesso, per effetto della proliferazione di software dedicati (Motu Digital Performer, Apple Logic Pro, Avid Pro Tools ecc.) che consentono la realizzazione di progetti musicali anche attraverso semplici PC di casa o laptop, l'industria musicale, costretta oltretutto da un fatturato agonizzante per la grave crisi del mercato discografico, ha notevolmente ridotto - se non annullato - l'impiego dei tradizionali team di produzione, tagliando in tal modo risorse umane ed investimenti. In questa cornice va pure inquadrato il ruolo del sound engineer destinato a gestire il suono con un approccio più operativo che creativo rispetto al passato, in virtù del fatto che nuovi generi musicali (in cui prevale di gran lunga la componente elettronica su quella elettrica o acustica) impongono al suo lavoro una rigorosa attenzione alle risorse di marchingegni digitali creati appositamente per restituire suoni già fatti da banchi campionati: insomma qui la competenza professionale del produttore e dell'ingegnere è maggiormente al servizio di una sofisticata tecnologia digitale, con approcci e orientamenti diversi rispetto ai ruoli del passato.
A questo aggiungo che l'industria musicale, o quello che attualmente resta di essa, contro una sua nativa vocazione, licenzia - e non più produce in proprio - da piccole etichette indipendenti master realizzati a buon mercato, per poi commercializzare dei prodotti non più distribuiti dai tradizionali punti di vendita (negozi o store specializzati), ma affidati ad applicazioni (Apple Music/iTunes, Spotify ecc.) che riproducono file multimediali permettendo l'acquisto on line di canzoni facenti parti di interi cataloghi discografici, o video di concerti dal vivo. Data la mia posizione critica riguardo alle disamine ora fatte, riterrei più adeguato invocare rimedi più che esprimere previsioni circa il futuro della musica prodotta e riprodotta; rimedi che abbiano come denominatore comune il fine di restituirle dignità artistica a ogni assunto musicale inducendo l'utente non tanto a servirsi del prodotto per uno svago transitorio, quanto abituarlo all'educazione dell'ascolto e alla cultura del suono, riscoprendone la gradevolezza timbrica e l'incedere dinamico, qualità oggi gravemente compromesse da un approccio standardizzato e superficiale all'ascolto della musica riprodotta, asservita questa al trend del volume alto a ogni costo che restituisca all'ascoltatore, dal vivo o su supporto, una sonorità sempre esasperata ed uniforme, indipendentemente dallo stile o dal genere musicale che la rappresenti; rimedi infine che restituiscano la musica ai musicisti, a tutti quelli che la compongono, la suonano, la arrangiano, la registrano e la confezionano per farla diventare bella e godibile a chi la ascolti!